Alimenti dannosi per la prostata e alimenti che la proteggono ( di Claudia Santini ) (rivisto da S.C.)
Il peperoncino, considerato da sempre un afrodisiaco, rientra tra gli alimenti dannosi per la prostata, con possibili ripercussioni anche sulle sfera sessuale.
Tra gli altri alimenti dannosi per la prostata troviamo: la birra, i crostacei (altro alimento noto per le sue proprietà afrodisiache), spezie, insaccati, pepe, superalcolici e caffè. Sono questi, infatti, i cibi di cui non abusare, evidenziati nel decalogo messo a punto dalla Società italiana di urologia (Siu) in occasione della giornata europea di informazioni sulle malattie prostatiche.
Il decalogo punta a essere una vera e propria dichiarazione di guerra al tumore alla prostata. Vincenzo Mirone, presidente del Siu, a margine dell’incontro, spiega che a rendere peperoncino, birra, crostacei e altri alimenti ‘nemici’ della prostata “è quello stesso elemento che li rende noti come afrodisiaci. Questi cibi, infatti, irritano la prostata, stimolando la necessità di eiaculare“.
Il decalogo raccomanda di consumare più cibi contenenti sostanze antiossidanti, ovvero ricchi di vitamine A, C, E, selenio, zinco e manganese, quali: carote, broccoli, cavolfiori, peperoni (?), noci, carni rosse, fegato e cereali integrali. L’autrice dell’articolo e gli Specialisti riardano inoltre di bere almeno due litri di acqua al giorno per ridurre il peso specifico delle urine ed evitare infezioni urinarie da ristagno perché fenomeni infiammatori della vescica si possono trasmettere per contiguità alla prostata e peggiorare quindi il caso clinico.
Cibi che “aiutano” il sesso
Di Claudia Santini (semplificato e rivisto da S.C.)
Esistono, per aiutarci a godere maggiormente degli effetti benefici del pasto, cibi afrodisiaci. Già anticamente ad essi venivano attribuite proprietà in grado sia di stimolare il desiderio sessuale che di aiutare le performance maschili. Questi ultimi vengono considerati afrodisiaci per la loro azione biochimica: spesso si tratta di erbe o spezie contenenti sostanze che migliorano la circolazione sanguigna, come melissa, prezzemolo, basilico, peperoncino, in qualità di “aiutanti” nell’amore. Gli stessi cibi con proprietà stimolanti vengono spesso considerati tali per analogia di forma o di funzione: il sedano, ad esempio, ortaggio dalle forme evocative messo sulla testiera del talamo nuziale per aumentare la fertilità; l’ostrica, offerta in genere dall’uomo alla donna – che richiama l’organo femminile ma al contempo è ricca di calcio e zinco, minerali molto preziosi per l’ars amatoria. Anche gli odori possono dare delle suggestioni “erotiche”: i Greci e i Romani consideravano l’aglio afrodisiaco perché una volta ben metabolizzato dall’organismo lasciava un leggero sentore che ricordava gli odori emanati dal corpo dopo l’attività sessuale.
Le analogie più immediate di alcuni cibi considerati afrodisiaci sono quelle che richiamano la funzione sessuale: i testicoli di toro, ad esempio.
La cucina floreale è considerata afrodisiaca poiché i fiori sono gli organi genitali delle piante, così anche per certi frutti, come la mela, il melograno o il kiwi, o i frutti degli ortaggi quali il cavolfiore o i broccoli.
Attenzione al cioccolato: se da una parte contiene sostanze stimolanti dall’altra è considerato un sostitutivo della sessualità, in più di una ricerca negli scorsi anni è risultato che la maggioranza delle donne preferiva rinunciare al sesso piuttosto che al cioccolato. Per quanto riguarda gli alcolici, meglio in piccole dosi, uno, due bicchieri al massimo: il vino provoca una leggera alterazione dello stato di coscienza e dei freni inibitori, se assunto in dosi maggiori l’effetto si rovescia e le prestazioni maschili precipitano. Lo champagne viene considerato la bevanda più afrodisiaca: certamente per il suo valore che ne fa un alimento di lusso e quindi consumato raramente, e per le sue tante bollicine, che avrebbero la capacità di rendere più spumeggiante chi ne beve. Effetto del tutto contrario lo produrrebbe invece la birra, in quanto prodotta con il luppolo, una pianta anafrodisiaca contenente ,tra l’altro, principi amari simil estrogeni ed antiandrogeni; la pianta, raccolta in primavera, veniva un tempo utilizzata per placare i bollori maschili. ( vedi e leggi Vitex Agnus Castus, pianta anafrodisiaca perché i suoi componenti contrastano le funzioni del testosterone ).
Quindi, per riassumere, le piante che facilitano il sesso sono:
– Aglio e cipolla. Hanno proprietà fluidificanti e il loro odore, specie quello dell’aglio, ricorda quelle delle secrezioni femminili durante l’atto sessuale.
– Cacao. Contiene sostanze sia benefiche e stabilizzanti sull’umore (feniletilamina) che stimolanti (teobromina). Il suo uso quindi ha dei pro e dei contro.
– Chiodi di garofano. La sua azione di momentanea desensibilizzazione sembra aiuti la sessualità.
– Coriandolo. Alle donne vengono consigliati i semi seccati, dall’effetto euforizzante, lasciati in infusione oppure utilizzati in cucina. Da usare con moderazione, per evitare effetti opposti.
– Noce moscata. Usata con parsimonia, a questa spezia viene attribuita la proprietà di risvegliare o migliorare la libido.
– Prezzemolo, basilico, menta, rafano, sedano, zenzero. Hanno tutti un’azione tonica e stimolano la circolazione. In più spesso le loro forme evocano gli organi sessuali.
– Peperoncino. Va usato in piccole dosi, si considera afrodisiaco sia perché contiene sostanze come la capsicina dall’effetto leggermente desensibilizzante, sia per il “fuoco” che contiene e che comporta un’irritazione alla quale segue, con lo stesso meccanismo del coleottero detto Cantaride (Cantharis vescicatoria o Lytta, o mosca spagnola), un desiderio pruriginoso di eiaculare.
– Rucola. È una verdura ricca di minerali, utili per l’attività sessuale e la circolazione.
– Salvia. Uno dei pochi afrodisiaci solamente femminili, ma quale fonte di fito-estrogeni è negativa per gli uomini. Particolarmente adatta per le donne ipersensibili, ha un’azione sia antispastica che stimolante per il sistema nervoso. Per non disperdere i principi attivi, in cucina va utilizzata insieme a una sostanza grassa, come il burro o l’olio.
– Sedano. Ricco di minerali e vitamine. Ha un’azione benefica su sangue e pressione sanguigna e attività muscolare. La radice è tradizionalmente la sua parte considerata afrodisiaca.
– Tartufo. Come altri cibi molto costosi (caviale, ostriche, champagne, aragoste) è considerato uno stimolante sessuale perché associato alla ricchezza e al piacere.
– Vaniglia. Il suo profumo particolare ha indirettamente un’azione di stimolante sessuale. Per esperienza personale anche il profumo dell’Ilang-Ilang è fortemente seduttivo nelle donne. Pare che Vaniglia combatta l’astenia sessuale, agendo sul sistema nervoso.
– Zafferano. Contiene delle sostanze ormono-simili che sarebbero in grado di innescare o aumentare il desiderio sessuale.
Vengono considerati inibitori anche altri vegetali quali Cetrioli, Lattuga, Melone e Zucca.
A parziale correzione, meglio, quale doverosa integrazione a quanto scritto da Claudia Santini, riporto integralmente il Servizio di Viviano Domenici pubblicato sul Corriere della Sera. Ritengo inoltre che parlando di zucca debba esser ben evidenziato come siano i semi di zucca, fonte di ogni virtù salutistica, all’indice per quanto riguarda la questione libido maschile perché questi piccoli scrigni salutari contengono oltre a ………….. fitormoni estrogenici che possono interferire sull’equilibrio ormonale dell’uomo anziano che vede fisiologicamente e progressivamente calare il tasso del testosterone e all’opposto aumentare quello degli estrogeni.
***
Lattuga, il viagra naturale degli Egizi
La pianta che dette origine alle nostre insalate contiene una sostanza afrodisiaca.
Da oltre un secolo gli archeologi cercavano di spiegare un’ associazione apparentemente insensata: negli antichi bassorilievi egiziani, il dio della fertilità Min è sempre raffigurato sessualmente eccitato; davanti a lui i fedeli ( maschi) invocano il suo miracoloso aiuto offrendogli cespi di lattuga, una verdura adatta a propiziare sonni tranquilli piuttosto che brillanti prestazioni sessuali. Eppure, quei bassorilievi parlano chiaro: Min è inequivocabilmente « itifallico » e i geroglifici sottolineano che il suo membro si accendeva di visibile desiderio e la sua faccia si illuminava di entusiasmo proprio perché i fedeli gli offrivano della lattuga. Insomma, al dio Min la lattuga faceva un « effetto Viagra » e gli antichi egizi lo sapevano così bene che quando nemmeno la lattuga faceva l’ effetto sperato, si rivolgevano al dio per chiedere il suo miracoloso intervento. Naturalmente, portandogli in dono cespi di lattuga. Già nell’ antichità questa preziosa conoscenza andò perduta e nel mondo greco romano si diffuse l’ idea contraria, cioè che la lattuga fosse un ottimo calmante sessuale. Il celebre medico greco Dioscoride, ad esempio, sosteneva che bere il seme di lattuga domestica evitava le fantasie erotiche notturne « et proibisce l’ uso di Venere » ; il romano Plinio premeva sullo stesso tasto parlando di un tipo di lattuga che già dal nome ( astytis = « non sono in erezione » ) annunciava desideri blandi e sicuri insuccessi sessuali. Passarono tanti secoli e la lattuga arrivò ai nostri giorni con la sua fama di leggero sedativo generale adatto persino a calmare bambini insonni. Solo gli egittologi continuavano a interrogarsi sulla strana associazione tra le vistose esuberanze di Min i cespi di lattuga, ma il mistero sembrava destinato a rimanere tale. Ora l’ enigma è stato risolto e la vecchia lattuga ha rivelato preziose caratteristiche dimenticate da millenni: assunto a basse dosi, il lattice che affiora dagli steli fioriferi spezzati della Lactuca serriola , una lattuga selvatica « madre di tutte le lattughe » , è davvero un blando calmante ma, a dosi maggiori, garantisce un sicuro « effetto Min » . A risolvere l’ enigma è stato il paleobotanico italiano Giorgio Samorini, specialista di piante e composti psicoattivi e direttore della rivista « Eleusis » , edita dal museo Civico di Rovereto ( Trento). Samorini ha affrontato il problema partendo dalle origini, cioè prendendo in esame l’ amara lattuga selvatica ( Lactuca serriola ) che gli egizi coltivavano almeno fin dal IV III millennio avanti Cristo e con la quale produssero, per selezione, le varie specie di lattughe che noi tutt’ oggi mangiamo. « Quando è raffigurata sulle tavole d’ offerta – spiega Samorini – la lattuga è disegnata come singola pianta di colore verde azzurro e la vediamo adagiata sotto mazzi di ” ninfea azzurra”, un altro vegetale con proprietà psicoattive. In altri casi è raffigurata verticalmente, alternata a vasi pieni di vino, e ha una forma appuntita, a cipresso, che ne rende più difficile l’ identificazione. Considerazioni di carattere etnobotanico mi hanno portato alla convinzione che la lattuga di Min fosse una lattuga selvatica, la Lactuca serriola; appunto quella che ho preso in esame. Con una serie di auto sperimentazioni ho verificato che assumendo fino a 1 grammo di lattucario , il lattice che affiora dagli steli recisi, prevalgono gli effetti sedativo analgesici dovuti alla presenza di sostanze come lattucina e lattupicrina; a dosi maggiori, cioè 2 o 3 grammi, prevale invece l’ effetto stimolante e allucinogeno indotto dall’ alcaloide tropanico, una sostanza presente nelle Solonacee allucinogene quali il giusquiamo, la mandragora e la datura » . « Queste differenti reazioni dovute al diverso dosaggio – continua Samorini – possono spiegare perché in Europa, essendo noti solo gli effetti analgesici e simil oppiacei, prevalse per secoli l’ idea che la pianta avesse la capacità di spegnere gli ardori sessuali degli adulti e di favorire il sonno dei più piccoli. In alcune aree della Calabria è rimasta l’ usanza, nel giorno della commemorazione dei defunti, di consumare l’ amara lattuga selvatica e di bere vino accanto alle tombe dei parenti. Insomma, continua l’ impiego della lattuga selvatica come calmante. In Egitto, invece, sembra che Min abbia lasciato qualche ricordo ed è opinione diffusa che chi mangia tanta lattuga avrà tanti figli » . La Lactuca serriola è tutt’ oggi la più comune fra le specie selvatiche del bacino del Mediterraneo. Cresce a cespi isolati nei prati, ma anche in città, lungo i muri o a ridosso dei marciapiedi, ma per i non esperti è difficile riconoscerla come una lattuga. Ha foglie allungate dal contorno frastagliato e un colore azzurrognolo che permette di distinguerla dalle altre specie selvatiche. Da millenni è sotto gli occhi di tutti, ma da tempo avevamo dimenticato il tesoro nascosto nel suo lattice bianco. Tesoro che ora Samorini ha riportato alla luce. « Credo che il mio studio abbia risolto un enigma etnobotanico e dato una spiegazione convincente dell’ associazione tra il dio Min e la lattuga – conclude il paleobotanico – , ma non credo affatto che la scoperta del potere afrodisiaco del lattucario possa avere qualche ricaduta pratica. Oggi in farmacia si possono trovare soluzioni decisamente più pratiche dell’ andare per prati in cerca di Lactuca serriola » .
Domenici Viviano
(19 giugno 2005) – Corriere della Sera, pag 27
***
ANTOCIANINE ovvero FRAGOLE, LAMPONI …
Le antocianine, una classe di flavonoidi contenuti in tali frutti, sono in grado di inibire la crescita di cellule tumorali e di stimolarne l’apoptosi – o morte programmata – in ratti trattati con cancerogeni dei tessuti dell’esofago
Uno studio pubblicato sull’ultimo numero della rivista “Cancer Prevention Research”, organo dell’American Association for Cancer Research, indica alcuni componenti presenti nelle more come importanti nella prevenzione dei tumori. La ricerca, svoltasi presso l’Ohio State Comprehensive Cancer Center, ha concluso infatti che le antocianine, una classe di flavonoidi contenuti in tali frutti, sono in grado di inibire la crescita di cellule tumorali e di stimolarne l’apoptosi – o morte programmata – in ratti trattati con cancerogeni dei tessuti dell’esofago. Agli animali è stata somministrata polvere di more disidratate con dosi di 60 grammi al giorno. “I nostri dati forniscono una forte evidenza di quanto le antocianine siano importanti per la prevenzione del cancro, si tratta dei primi risultati di questo tipo per uno studio in vivo, a conferma di altri studi effettuati su cellule in vitro”, ha commentato Gary D. Stoner, docente del Dipartimento di medicina interna dell’Ohio State University e coautore della ricerca. “Ora che sappiamo che le antocianine sono efficaci quasi quanto i frutti interi, speriamo di poter dare il via alla valutazione dell’efficacia di questo trattamento anche nell’uomo utilizzando una miscela standardizzata di antocianine.”
***
Approfondimento: Antociano
(Da Wikipedia, l’enciclopedia libera)
Gli antociani (dal greco anthos = fiore, kyáneos = blu) o antocianine sono una classe di pigmenti idrosolubili appartenente alla famiglia dei flavonoidi.
Le antocianine sono tra i più importanti gruppi di pigmenti presenti nei vegetali, e si ritrovano nei fiori e frutti così come negli arbusti e nelle foglie autunnali. Il colore delle antocianine può variare dal rosso al blu e dipende dal pH del mezzo in cui si trovano e dalla formazione di sali con metalli pesanti presenti in quei tessuti. Ad esempio, la cianina costituisce il colore di alcune dalie e del fiordaliso.
Le antocianine sono presenti, seppur con diverse quantità, in quasi tutte le piante superiori (ma non nel cactus e in altre ancora), e si trovano specialmente nei frutti e nelle infiorescenze, ma si possono riscontrare anche su foglie e radici, molto spesso insieme ad altri pigmenti quali carotenoidi e flavonoidi. Insieme sono responsabili della colorazione delle foglie delle piante caducifoglie in autunno, quando la fotosintesi si interrompe così come la produzione di clorofilla.
Le antocianine svolgono un ruolo importante anche in piante giovani o con getti nuovi, proteggendole dai raggi ultravioletti quando la produzione di clorofilla e di cere non è ancora iniziata. A questo punto anche l’intera pianta può assumere una colorazione rosso-brunastra (come ad esempio i nuovi getti di rose in primavera), che si riduce man mano che la produzione di clorofilla inizia.
| alimenti | Antocianine in mg per 100 g alimento |
| melanzana | 750 |
| arancia | ~200 |
| mora | ~115 |
| lampone | 10-60 |
| ciliegia | 350-400 |
| ribes | 80-420 |
| pompelmo rosso | 30-750 |
| uva nera | 888 |
| vino rosso | 24-35 |
La produzione e la quantità di questi pigmenti dipendono dal tipo di pianta e da altre condizioni esterne quali natura del suolo, temperatura e luce. Alimenti ricchi in queste sostanze sono il ribes, la ciliegia, il cavolo rosso, l’uva, la fragola, il sambuco e le bacche in generale.
Altri alimenti in cui gli antociani sono presenti, seppur in minor quantità, sono la banana, l’asparago, il pisello, la pera e la patata. La colorazione di tali sostanze è così forte da mascherare spesso gli altri pigmenti.
Le antocianine sono presenti esclusivamente in piante superiori, e non si riscontrano in animali, microorganismi o piante acquatiche. Il motivo è che la biosintesi di queste sostanze richiede materiali originati solamente attraverso la fotosintesi e richiede una relativamente elevata intensità luminosa che non può essere raggiunta sott’acqua.
Le antocianine hanno diversi compiti. Grazie al loro potere antiossidante, proteggono le piante dai danni causati dalle radiazioni ultraviolette, assorbendo luce di una determinata lunghezza d’onda. Infatti in caso di esposizione a grandi quantità di radiazioni UV, la loro produzione aumenta immediatamente per compensare questa emergenza. Grazie ai loro colori poi questi pigmenti sono in grado di attirare insetti ed animali, provvedendo così un aiuto per la riproduzione delle piante e il trasporto dei semi. Inoltre sono in grado di assorbire luce blu – verde e questo è stato dimostrato proteggere le piante nei momenti di illuminazione elevata in combinazione con siccità o basse temperature.
Caratteristiche
Gli antociani sono composti poliaromatici poliossidrilati in grado di reagire con gli ossidanti quali l’ossigeno molecolare e i radicali liberi riducendo così i danni che queste molecole possono provocare alle cellule ed ai tessuti.
melanzana
Grazie a questa loro attività antiossidante e antiradicalica, queste sostanze possono essere molto utili per i loro impieghi in medicina. Questi pigmenti sembrano proteggere contro la fragilità capillare e contro vari processi di invecchiamento o modificazioni cellulari provocati dall’ossigeno, tra cui processi infiammatori e modificazioni cancerogene Alcune di queste attività sono le stesse riscontrate nel vino.
Questi pigmenti possono essere inoltre utilizzati come indicatori di pH, virando dal rosso al violetto o blu con l’aumentare dell’alcalinità dell’ambiente.
Gli antociani sono anche impiegati come additivi alimentari e sono presenti come colorante rosso antociano (E163), usato in marmellate e altri alimenti normalmente con pH acido come lo yogurt.
Industrialmente le antocianine si estraggono dalla buccia dell’uva rossa, come sottoprodotto dell’industria enologica. L’estrazione avviene con acidi diluiti e il prodotto è un liquido contenente zuccheri, acidi, sali e pigmenti originariamente presenti nella buccia. Per essiccazione si ottiene una polvere idrosolubile relativamente ricca in questi pigmenti.
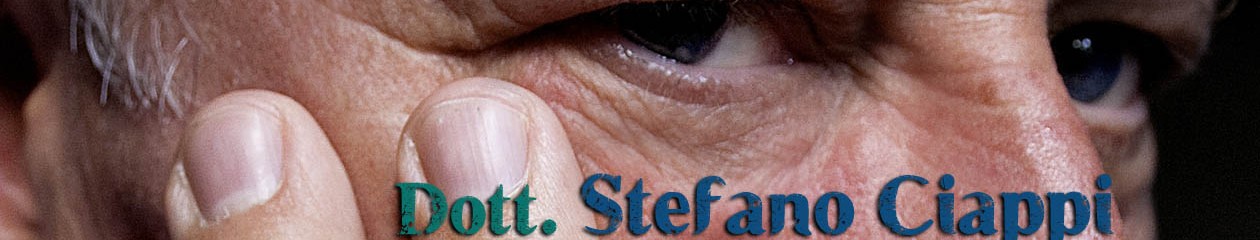

la cosa seria,sarebbe di mangiare di tutto…ma la cosa piu’ bella’, viene spontaneo dire..alimenti affrodisiaciiii
Grazie.