I POLLINI (http://www.allergyverona.it)
(parzialmente rivisto ed ampliato da S.C.)
I pollini presenti nell’atmosfera rappresentano i semi maschili delle piante, liberati nell’aria durante la stagione di fioritura, quando le condizioni meteorologiche sono idonee, per garantire la riproduzione.
Non tutte le piante liberano polline in grado di indurre manifestazioni allergiche. Il polline, per determinare quadri clinici allergici, deve avere alcune caratteristiche:
- Appartenere a piante anemofile
- Contenere componenti allergeniche che stimolano il sistema immunitario del soggetto geneticamente predisposto a produrre anticorpi specifici IgE.
- Essere prodotto in grande quantità da piante assai diffuse sul territorio ed essere piccolo e leggero per essere trasportato dal vento a grande distanza.
L’impollinazione è il trasporto di polline dalla parte maschile a quella femminile dell’apparato riproduttivo (contenuto nei coni delle piante o nei fiori) della stessa pianta o di piante diverse. L’impollinazione rappresenta il principale meccanismo di riproduzione delle Gimnosperme e delle Angiosperme.
Esistono due tipi principali di impollinazione:
- l’autoimpollinazione o impollinazione autogama, si verifica allorquando il polline passa direttamente dall’antera di un fiore allo stigma dello stesso fiore. Le piante che praticano questo tipo di impollinazione sono dette autogame.
- la impollinazione incrociata o impollinazione eterogama, si verifica allorquando il polline viene trasportato dall’antera di un fiore allo stigma del fiore di un individuo differente della stessa specie . Le piante che praticano questo tipo di impollinazione sono dette allogame.
Le piante anemofile producono grandi quantità di granuli pollinici, invisibili ad occhio nudo che vengono trasportati dal vento anche a distanze considerevoli; solo una piccolissima quantità di pollini andrà a fecondare il seme femminile della stessa specie mentre la massima parte va dispersa andando a depositarsi su varie superfici comprese mucose congiuntivali e delle vie aeree dei soggetti allergici.
Si parla di impollinazione anemogama. Questa modalità di propagazione dei pollini spiega perché i soggetti possono presentare reazioni allergiche al polline di piante che non crescono nelle immediate vicinanze. La maggior parte delle piante con importanza allergologica appartengono a questo gruppo.
Le piante entomofile liberano piccole quantità di pollini, generalmente grossi e pesanti che vengono trasportati dagli insetti su un altro fiore della stessa specie. (vedi sopra). Questi fiori sono di solito colorati e odorosi per attirare gli insetti.
Si parla di impollinazione entomofila. Questi pollini sono presenti in bassa concentrazione nell’atmosfera e rivestono quindi scarsa importanza allergologica. Tuttavia possono essere responsabili di allergia in soggetti frequentemente esposti a tali piante come per esempio giardinieri e fioristi.
I pollini hanno dimensioni che variano a seconda della specie da un minimo di 5 micron ad un massimo di 200 micron. Il granulo pollinico è costituito da:
- un rivestimento esterno (esina) che presenta caratteristiche diverse nelle varie specie vegetali.
- uno strato interno (intina) che contiene numerose proteine o glicoproteine allergizzanti che vengono liberate a livello delle mucose varie (congiuntive, vie aeree, orofaringee.. ) causando le manifestazioni allergiche vere e proprie. (vedi poi reazioni crociate o cross-reattive).
Il periodo in cui avviene l’impollinazione è diverso per le varie specie vegetali.
Le diverse condizioni meteo e climatiche delle varie regioni italiane portano ad una differente distribuzione delle famiglie botaniche sul territorio e a variazioni nel loro periodo di fioritura.
Ogni specie ha il suo proprio periodo di fioritura, ma ogni anno le condizioni atmosferiche influenzano l’inizio della stagione pollinica e la concentrazione dei pollini nell’aria:
- l’aria secca e calda facilita la pollinazione e favorisce come il vento la dispersione dei pollini.
- l’eccessiva umidità tende a ritardare la pollinazione e la pioggia fa cadere i pollini al suolo.
- un periodo di pioggia eccessiva prima della stagione pollinica favorisce la crescita delle piante e quindi una maggiore produzione di pollini. Ma se la pioggia è seguita da abbondante soleggiamento con evaporazione rapida dell’acqua la pianta produrrà polline scarsamente vitale.
Graminacee
Rappresentano la principale famiglia botanica diffusa in ambienti erbacei come pascoli, prati e terreni, coltivati ed incolti. Sono presenti a varie latitudini, adattandosi a condizioni climatiche disparate; crescono dal livello del mare fino alla fascia alpina. Molte specie sono spontanee (erbe infestanti) mentre altre vengono coltivate per l’alimentazione umana o degli animali. L’emissione dei pollini avviene da aprile a ottobre con concentrazioni nell’aria più elevate tra aprile e giugno. Le graminacee spontanee liberano grandi quantità di pollini in atmosfera a differenza delle specie coltivate. Il periodo di impollinazione delle graminacee inizia più tardivamente nelle zone montane e nei paesi del Nord-Europa. L’alternarsi di periodi di pioggia con periodi di sole possono causare ripetute fioriture che determinano un prolungamento della stagione di impollinazione con conseguente andamento protratto della sintomatologia allergica.
Principali graminacee spontanee e loro periodo di pollinazione
Caprinella (Agropyron repens) da maggio a settembre
Paleo odoroso (Anthoxanthum odoratum) da marzo a luglio
Erba canina (Cynodon dactylon) da giugno ad ottobre (vedi foto)
Erba mazzolina (Dactylis glomerata) da maggio a settembre (vedi foto)
Paleo dei prati (Festuca arundinacea) da aprile a luglio (vedi foto)
Bambagiona (Holcus lanata) da giugno ad agosto
Loglierella (Lolium perennis) da maggio ad agosto (vedi foto)
Coda di topo (Phleum pratensis) da maggio a luglio (vedi foto)
Gramigna dei prati (Poa pratensis) da aprile ad agosto (vedi foto)
Principali graminacee coltivate (cereali) e loro periodo di pollinazione
Avena (Avena sativa) da maggio ad agosto
Orzo (Hordeum vulgare) da aprile ad agosto
Segale (Secale cereale) da giugno a luglio (vedi foto)
Grano (Triticum aestivum) da maggio a giugno
Mais (Zea mays) da luglio a settembre
Urticacee
Di questa famiglia il genere Parietaria riveste maggiore importanza allergologica.
È un’erba infestante che cresce soprattutto sui muri, nelle fessure delle rocce (da cui il nome “erba muraria o muraiola”)( vetriola in Toscana perché usata storicamente per pulire a fondo i fiaschi), nei terreni secchi ed incolti. È diffusa dalla pianura fino a 900-1000 metri di altitudine. In Italia le specie più frequenti sono:
- P. judaica: presente in tutta Italia ma in particolare nelle regioni centro-meridionali, nelle isole ed in Liguria.
- P. officinalis: presente nelle aree collinari in particolare in Italia settentrionale.
- P. mauritanica: presente solo in Sardegna ed in Sicilia.
La fioritura, con alcune differenze tra Nord, Centro e Sud Italia avviene da Febbraio a Novembre: nell’Italia settentrionale i picchi di impollinazione vengono registrati in maggio-giugno e nel periodo fine agosto – settembre, mentre andando verso il centro e il sud i periodi di pollinazione si fanno sempre più lunghi tanto che nell’Italia meridionale ed insulare la fioritura è quasi perenne.
I soggetti con allergia alla parietaria presentano spesso una positività isolata per questo allergene (monosensibilizzazione).
Le piccole dimensioni del granulo pollinico (14-18micron) favoriscono la sua penetrazione nelle basse vie aeree e la presenza di apparati filiformi nello strato esterno del polline permette al polline di funzionare da supporto a inquinanti atmosferici (esempio metalli pesanti quale il piombo) che vengono veicolati nelle vie respiratorie, causando infiammazione e fenomeni irritativi di lunga durata (con conseguente labilità, iper-reattività bronchiale) .
Composite o Asteracee
Di questa famiglia hanno importanza allergologica i generi Artemisia ed Ambrosia ad impollinazine anemofila.
L’Artemisia o Assenzio selvatico cresce ai margini delle strade, lungo le ferrovie, nei prati in tutta l’Italia e in Europa. Durante la fioritura, nei mesi di settembre-ottobre, libera grandi quantità di pollini che però, a causa del loro peso, risultano difficilmente aerodispersi.
L’Ambrosia è un’erba infestante importata accidentalmente in Italia dagli Stati Uniti negli ultimi decenni. I semi di ambrosia sono giunti in Italia anche come inquinanti di sementi di cereali e ciò spiega perché i primi casi di pollinosi da ambrosia sono stati registrati in particolare in Lombardia, nelle vicinanze di aeroporti e ai margini delle autostrade. La diffusione dell’ambrosia è in costante incremento, attualmente è diffusa non solo in Lombardia e Piemonte ma anche nel Veneto e nel Friuli. La fioritura è tra agosto e settembre. Il polline di ambrosia ha dimensione tra 15-24 micron metri ed è un allergene molto potente.
Oleacee (Olivo, Frassino, Ligustro)
L’Olivo è diffuso in tutta l’area Mediterranea. Può essere spontaneo o coltivato, cresce in luoghi rocciosi e secchi fino ad altezze di 600-700 metri.
Le concentrazioni polliniche atmosferiche possono variare da 100-200 granuli per metri cubi d’aria a 2000-3000 granuli nelle zone con coltivazioni molto intensive (esempio in Puglia) però, per fortuna, il periodo di pollinazione dura in genere non oltre i trenta giorni (maggio-giugno), sovrapponendosi al periodo di fioritura delle Graminacee. L’alternanza annuale della quantità di pollini (ad un’annata con elevate concentrazioni polliniche segue spesso un’annata con concentrazioni molto ridotte) spiega le variazioni da un anno all’altro del quadro clinico della pollinosi da olivo.
Un soggetto allergico all’olivo può presentare sintomi anche quando inala allergeni liberati da pollini di specie che appartengono alla famiglia delle Oleacee come il Frassino e il Ligustro il cui periodo di fioritura va da aprile a giugno.
Betullacee (Betulla, Ontano)
La betulla è diffusa in tutta Europa, in particolare nei paesi scandinavi ove questa pianta è al primo posto tra le cause di pollinosi. In Italia la betulla si ritrova nei boschi delle Alpi e degli Appennini da 900 a 1800 metri di altitudine. Negli ultimi anni questo albero è sempre più utilizzato come pianta ornamentale nei giardini di nuovi insediamenti urbani di numerose città italiane, soprattutto nell’Italia settentrionale. Per questo motivo ed a causa del notevole potere allergenico del polline di betulla, la pollinosi da betulla rara in passato in Italia è attualmente in progressivo aumento. Le betulacee hanno una pollinazione precoce (marzo–maggio) causando una pollinosi pre-primaverile.
la comparsa dei sintomi nella quasi totalità dei soggetti mentre una concentrazione di 30 granuli per m3 determina il mantenimento della sintomatologia nel corso della stagione di pollinazione in quanto le mucose del soggetto sono già sede di infiammazione (mucose iper reattive). Il soggetto allergico alla betulla accusa frequentemente, oltre alla rinite e congiuntivite, sintomi a livello della mucosa orale (Sindrome orale allergica) allorché ingerisce taluni alimenti come mela, kiwi, pera, ciliegia, carota, cioè frutta e verdura che possiedono allergeni comuni (cross-reattivi) tra pollini e alimenti vegetali.
Gli Ontani sono alberi diffusi dalle pianure fino a 1200-1600 m di altitudine.
L’Ontano nero, il più comune, si ritrova spesso lungo i corsi d’acqua, in particolare nelle zone appenniniche e prealpine. L’Ontano bianco è diffuso in particolare nelle regioni settentrionali. Durante il periodo di pollinazione, in genere in febbraio-aprile talvolta anche più precocemente dicembre-gennaio, l’Ontano libera enorme quantità di pollini ma con potere allergenico inferiore a quello dei pollini di betulla.
Corylacee (Nocciolo e Carpino)
Il Nocciolo è presente in tutta Europa, può crescere spontaneamente od essere coltivato per la produzione del suo frutto (nocciola) . Produce grandi quantità di pollini durante i mesi invernali da gennaio a marzo. I sintomi dell’allergia a nocciolo tendono spesso a perdurare nel tempo a causa della reazione crociata con i pollini di Ontano e Betulla, piante con la stessa distribuzione geografica e la cui fioritura va fino a maggio. I soggetti allergici al polline di nocciolo possono presentare manifestazioni allergiche (orticaria-angioedema) in seguito ad ingestione di nocciole (vedi cross-reattività).
Cupressacee/Taxodiacee
Della famiglia delle Cupressacee fanno parte il Cipresso comune, la Thuja e il Ginepro che si ritrova in tutte le regioni, dal livello del mare ad oltre 3000 metri.
Negli ultimi anni i soggetti che soffrono di pollinosi invernale da Cipresso sono in aumento, in particolare in Toscana, Puglia, Liguria, Umbria, Lazio e Campania ove è aumentata la coltivazione del Cipresso a scopi ornamentali o di rimboschimento.
Il periodo di pollinazione del Cipresso comune (Cupressus sempervirens) va in genere da febbraio a fine marzo con possibili anticipi a gennaio o continuazioni fino ad aprile con concentrazioni polliniche che possono raggiungere valori elevati di oltre mille granuli per metro cubo di aria, mentre il Cipresso dell’Arizona (importato di recente dall’America e utilizzata il più delle volte per allestire delle siepi) inizia a fiorire anche a dicembre in concomitanza con il Nocciolo.
I soggetti allergici al Cipresso presentano, in genere, sintomi anche se inalano pollini di Thuja (pianta ornamentale con fioritura tra marzo e aprile) o di Ginepro (fioritura tra febbraio e maggio).
La Criptomeria o Cedro del Giappone, pur non appartenendo alla famiglia delle Cupressacee ma a quella delle Taxodiacee, produce pollini con allergeni che possono indurre l’insorgenza di manifestazioni cliniche nei soggetti con allergia al cipresso. La Criptomeria è stata importata dal Giappone in Europa, a metà del secolo scorso ed è ora diffusa in Italia nelle regioni centro-settentrionali, come pianta ornamentale nei giardini e nelle regioni meridionali ove è utilizzata per il rimboschimento. Libera grandi quantità di pollini tra febbraio ed aprile.
Consigli utili per il paziente allergico a pollini
- Consultare i calendari pollinici per sapere il periodo di fioritura della pianta a cui si è allergici e per potere iniziare una profilassi-terapia farmacologica che andrà prolungata durante tutto il periodo di pollinazione.
- Evitare passeggiate nei prati, in zone ove l’erba è stata tagliata di fresco e gite all’aperto specialmente nei giorni di sole con vento e tempo secco, durante i periodi di massima impollinazione della pianta a cui si è allergici
- Evitare attività sportiva in campi o in prossimità di aree verdi
- Evitare di tagliare l’erba od i lavori di giardinaggio nel periodo di fioritura della pianta “nemica”
- Usare appropriate mascherine durante i lavori all’aperto
- Evitare i viaggi in macchina od in treno con i finestrini aperti. Quando possibile è preferibile viaggiare in autoveicoli con aria condizionata e filtri di aerazione anti-polline da pulire spesso
- Evitare l’aerazione degli ambienti durante le ore più calde della giornata ed eventualmente usare condizionatori d’aria
- Scegliere per le vacanze località e periodi ove sia bassa la concentrazione del polline a cui si è allergici, può essere consigliato il soggiorno marino durante il periodo della fioritura delle graminacee od anche il soggiorno montano sopra i 1000 metri per gli allergici alla parietaria.
Le misure preventive ambientali nel caso delle pollinosi sono di difficile attuazione, è quindi opportuno che il paziente con pollinosi si rivolga all’allergologo, prima della stagione pollinica, per stabilire un corretto programma preventivo-terapeutico. Allo scopo di ridurre quanto più possibile i sintomi dovuti all’esposizione al polline responsabile può essere utile, in alcuni casi, iniziare un‘immunoterapia allergene-specifica (I.T.S.) che consiste nella somministrazione di dosi crescenti dell‘allergene responsabile (prescritta dall’allergologo dopo esecuzione dei test diagnostici) .
Ovviamente questo non è l’atteggiamento terapeutico omeopatico di cui parleremo in seguito, anche per non occupare spazio al sito web dal quale ho tratto l’argomentazione e descrizione del quadro eziopatogenetico delle reazioni allergiche ai pollini ovvero, come vedremo ora, alle molecole glicoproteiche in essi contenute e che si ritrovano, diciamo pure subdolamente, in alcuni alimenti tanto che possono peggiorare, scatenare e rafforzare la reattività allergica stagionale fino a causare casi clinici importanti e talora fatali. Si parlerà ora della così detta cross-reattività.
Per impostare in tal senso la presentazione di tale aspetto della reattività allergica, mi sono permesso di modificare lo schema espositivo apparso nell’articolo del sito: http://www.allergyverona.it “I Pollini” da cui è stato tratto quanto segue:
POLLINOSI ED ALLERGIE ALIMENTARI
Circa il 25 % dei soggetti affetti da pollinosi presentano manifestazioni cliniche di allergia alimentare a frutta e verdura. Questo problema è più frequente nei pazienti allergici a più tipi di pollini (polisensibilizzati). La pollinosi precede quasi sempre la comparsa dell’allergia alimentare.
Il paziente può accusare:
- La sindrome orale allergica: caratterizzata da sintomi orali immediati nei punti di contatto con l’alimento (prurito, bruciore al palato, alla lingua, alle labbra con eventuale gonfiore della mucosa oro-labiale, senso di costrizione al faringe, disturbi della deglutizione).
- Quadri clinici o sintomi extra-orali dopo 15-60 minuti dall’assunzione dell’alimento (sintomi gastrointestinali, orticaria/angioedema, edema laringeo, rinite, asma, congiuntivite , edema palpebrale, deformazione congiuntivale … fino allo shock anafilattico).
Pollini con allergeni in comune (cross-reattivi) con alimenti
- Betulla, cipressi, ontano, nocciolo, carpini: mela, pera, pesca, albicocca, prugna, ciliegia, nocciola, noce, mandorla, nespola, arachide, lampone, fragola, kiwi, sedano, finocchio, carota, prezzemolo.
- Graminacee: frumento, melone, anguria, pomodoro, arachide, pesca, ciliegia, albicocca, prugna, mandorla, kiwi, agrumi.
- Artemisia, ambrosia: lattuga, cicoria, tarassaco, camomilla, olio di girasole, margarina, banana, castagna, sedano, finocchio, carota, prezzemolo, pepe verde, miele.
- Parietaria: basilico, ortica, melone, ciliegia, more di gelso, pisello.
B- POSSIBILI REAZIONI CROCIATE TRA POLLINI ED ALIMENTI.
Per approfondire tale aspetto inerente alle reazioni allergiche, riporto un altro articolo elaborato a tal proposito e che mi è sembrato ben fatto.
Autore: Dott.ssa Cinzia Baldo – Dietista – ICP P.O. Buzzi Milan
http://www.educazione nutrizionale granapadano.it
Reazione crociata o cross reazione: cos’è?
Il contatto con alcuni alimenti vegetali in pazienti allergici ad alcune famiglie di pollini può determinare una sindrome orale allergica con fenomeni irritativi a labbra e cavo orale: il sintomo più comune è rappresentato dal prurito al palato, ma può comparire anche gonfi ore delle labbra, fino ad edema della glottide.
Raccomandazioni Dietetiche
La sindrome orale allergica si manifesta pochi minuti dopo il contatto con alcuni alimenti vegetali. È utile per chi è allergico, ed ha manifestato fenomeni di cross reattività, conoscere le relazioni tra piante e alimenti vegetali. La raccomandazione principale rimane quella di evitare di consumare gli alimenti responsabili di sindrome orale allergica, durante il periodo di pollinazione. L’allergia ai pollini ha andamento tipicamente stagionale. Si manifestano solo in un determinato periodo dell’anno, quello cioè corrispondente alla fioritura della pianta a cui il polline appartiene.
Il caso più frequente è quello dell’allergia alle graminacee (erbe la cui fioritura avviene nel periodo da fine aprile a fine settembre) ma negli ultimi tempi si è assistito ad un progressivo aumento delle allergie ai pollini di altre specie vegetali. E’ il caso di alberi cosiddetti “a fioritura precoce” (da gennaio a marzo), come betulla, nocciolo, ma anche di altre piante, come l’ambrosia e il carpino, la cui allergia si è andata diffondendo a partire dalle zone vicino agli aeroporti, dove l’erba è stata trasportata “per via aerea”.
I consigli valgono soprattutto per il periodo a rischio, che varia a seconda del tipo di polline cui si è allergici.
All’aperto
Va consultato il calendario pollinico che indica i periodi dell’anno a rischio. In questi periodi si dovranno attuare i provvedimenti preventivi comportamentali (uso di mascherine, occhiali scuri, ecc) e farmacologici che permettano, ad adulti e a bambini, di vivere all’aria aperta senza incorrere nei fastidiosi disturbi a occhi, naso e bronchi.
Il bambino ha il diritto di frequentare regolarmente tutte le attività ricreative, gioco e sport, adeguate alla sua età, sotto il controllo di personale addestrato nello specifico.
Viaggiate in auto preferibilmente con i finestrini chiusi. Dotate l’automobile di un sistema di filtri per pollini, e ricordatevi di cambiarli regolarmente.
Evitate di posteggiare l’auto sotto gli alberi, e in prossimità di giardini e prati.
Non piantate nel vostro giardino alberi con pollini trasportati dal vento (come cipresso, betulla, nocciolo, carpino, ontano, olivo, faggio); preferite invece piante con impollinazione mediata da insetti (tiglio, ippocastano, robinia). Estirpate eventuali erbe infestanti.
In casa
Fate la doccia e lavate i capelli ogni sera (poiché i granuli di polline possono rimanere tra i capelli e depositarsi sul cuscino, da dove vengono inalati durante il sonno).
Ricordatevi che gli animali domestici possono diventare a loro volta trasportatori di pollini tramite il pelo.
Circa il 25% dei soggetti allergici ai pollini possono presentare disturbi immediati alla bocca (bruciore, prurito, gonfiore), o più tardivi in altre sedi, con l’assunzione di alcuni tipi di frutta e di verdura, quali, ad esempio:
- Mela, carota, sedano, finocchio, pera, banana, nespola, pesca, ciliegia, albicocca, prugna, prezzemolo, nocciola, noce, arachide, mandorla, kiwi, lampone, fragola, pepe verde in caso di allergia a BETULLACEE.
- Cicoria, tarassaco, camomilla, banana, anguria, castagne, arachide, noce, nocciola, pistacchio, sedano, prezzemolo, carota, finocchio, olio di girasole, margarine, dragoncello, lattuga, zucca, mela, melone, miele di girasole, miele di tarassaco in caso di allergia alle COMPOSITE.
- Pisello, arachide, soia, fagiolo, gelso, pistacchio, melone, kiwi, patata, basilico, ortica, ciliegia, basilico alla PARIETARIA.
- Sedano, orzo, avena, kiwi, mais, anguria, pesca, prugna, agrumi, riso, segale, frumento, pomodoro, melone, albicocca, ciliegia, mandorla, arachidi, bietole in caso di allergia alle GRAMINACEE.
- Sedano, melone, anguria, banana, carote in caso di allergia all’ASSENZIO e AMBROSIA.
In queste situazioni, quindi, attenzione alla dieta!
Dal momento che non tutte le persone allergiche ai pollini hanno necessariamente una allergia crociata agli alimenti e dal momento che non tutti gli alimenti elencati possono dare allergie nella singola persona è opportuno che sia il medico ad indicare caso per caso quale dieta seguire, allo scopo di limitare il rischio di squilibri nutrizionali. Seguite le indicazioni del medico circa l’uso dei farmaci per prevenire e curare le manifestazioni allergiche.
Calendario dei pollini
E’ necessario imparare a conoscere le piante e le erbe che liberano i pollini a cui si è sensibilizzati, e i relativi periodi di fioritura. L’andamento della concentrazione pollinica nell’aria varia considerevolmente a seconda del periodo dell’anno, del tipo di polline e della zona in cui si vive. Per questo esistono i calendari dei pollini, di solito realizzati da enti locali (ASL, Ospedali, ecc.), che forniscono anche dati aggiornati in tempo reale sulla concentrazione dei pollini nella vostra zona e “previsioni” a breve termine che possono consentirvi di personalizzare la gestione della vostra allergia …………..
Autore: Dott.ssa Cinzia Baldo – Dietista – ICP P.O. Buzzi Milan
http://www.educazione nutrizionale granapadano.it
*******
C – ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI
Si parla di allergia alimentare quando l’organismo reagisce in modo anomalo ad un alimento. In questa reazione viene coinvolto il sistema immunitario che, attraverso la formazione di anticorpi specifici (chiamati IgE ), ha il compito di difendere l’organismo da ogni pericoloso invasore, solitamente batteri e virus. In questo caso, per motivi ancora sconosciuti, l’organismo produce anticorpi nei confronti di alcuni alimenti che sono innocui per la maggior parte delle persone. La formazione di anticorpi avviene alla prima ingestione dell’alimento; in occasione di una successiva esposizione, a seguito della reazione fra l’alimento ”allergenico” e l’anticorpo, si libera una sostanza, l’istamina, che è la principale responsabile dei sintomi caratteristici di tutte le reazioni allergiche.
Il termine allergia alimentare è spesso usato in modo improprio anche quando sarebbe più opportuno parlare di intolleranza alimentare. In questi casi infatti non si tratta di una vera reazione allergica poiché il sistema immunitario non viene coinvolto.
Le allergie alimentari sono più frequenti in età infantile: alcune, come l’allergia alle uova e al latte, si attenuano col passare del tempo, talvolta fino a scomparire del tutto.
Come si manifestano?
Le allergie alimentari possono manifestarsi immediatamente dopo l’ingestione dell’alimento incriminato, a volte anche in modo violento. I sintomi di una intolleranza alimentare invece possono comparire anche a distanza di ore, in casi rari anche dopo alcuni giorni, il che rende più difficile riconoscerla e metterla in relazione con il cibo.
I sintomi variano quanto a rapidità e ad intensità a seconda della qualità e la quantità del cibo ingerito.
Quando il cibo ”incriminato” viene portato alla bocca e deglutito, può provocare immediatamente prurito e gonfiore alle labbra, al palato e alla gola; una volta nello stomaco e nell’intestino, può provocare nausea, vomito, crampi, gonfiori addominali, flatulenza, diarrea.
Al di fuori dell’apparato gastrointestinale, sono frequenti le reazioni cutanee come orticaria e angioedema (un gonfiore molto pronunciato e localizzato soprattutto attorno agli occhi e alle labbra) . Nei bambini si hanno più spesso sintomi a carico dell’apparato respiratorio (asma e rinite) e gli eczemi possono peggiorare.
Nei casi più gravi, fortunatamente rari, si possono avere difficoltà respiratorie, brusche cadute di pressione arteriosa, perdita di coscienza e persino morte. In questi casi si parla di shock anafilattico, che compare entro un’ora dall’ingestione dell’allergene e che richiede sempre un ricovero ospedaliero urgente.
Quali sono le cause?
Nel caso delle allergie vere e proprie, la causa è semplice e va ricercata in una reazione anomala del sistema immunitario. Fra gli alimenti più frequentemente coinvolti vi sono uova, crostacei, pesce, nocciole ed arachidi che possono causare reazioni allergiche immediate fino all’anafilassi.
L’allergia alle arachidi, molto diffusa in America, dove si fa un largo uso di semi e di burro di arachidi, è all’origine della proposta, alle compagnie aeree statunitensi, di abolire il consumo di noccioline a bordo.
Le cause delle intolleranze alimentari possono essere varie:
- assunzione di alimenti che, con meccanismo ignoto, inducono liberazione di istamina nell’organismo e possono provocare orticaria: fra questi soprattutto cioccolato, fragole, ananas, frutti esotici, crostacei, albume d’uovo, formaggi fermentati, cavoli, pomodori, spinaci, spezie;
- ingestione di alimenti contenenti, per loro natura, elevate quantità di istamina come sarde, tonno, aringhe, sgombri, salmone, crostacei, alcuni formaggi (gorgonzola, emmenthaler, camembert), salsicce, salame, coppa, pomodori, peperoni, banane, spinaci, alcuni vini (sia bianchi che rossi ), birra ecc. Anche questi alimenti possono dare luogo a orticaria;
In questi due casi si parla anche di PSEUDOALLERGIE perché tutti gli alimenti sopra indicati, assunti in grandi quantità, possono provocare sintomi simili a quelli di un’allergia vera e propria, in quanto si viene a determinare nell’organismo un eccesso di istamina. Si tratta comunque di casi in cui l’eliminazione dell’alimento incriminato non è tassativa: a meno che la sua ingestione non provochi reazioni molto gravi, basterà limitarne il consumo.
- deficit enzimatici ossia l’assenza di particolari sostanze, detti enzimi, di cui l’organismo ha bisogno per assimilare gli alimenti. Alcune persone sono prive fin dalla nascita di alcuni di questi enzimi e quindi non riescono ad assimilare e/o metabolizzare determinati alimenti o sostanze. Esempi ne sono l’alactasia, il favismo e la fenilchetonuria.
Infine, sono implicati frequentemente in reazioni allergiche o di intolleranza anche particolari sostanze o additivi contenuti negli alimenti, ad esempio:
- salicilati naturalmente presenti in alcuni alimenti (frutta secca, frutti di bosco, arance, albicocche, uva, olive, erbe aromatiche, vini, liquori). Possono essere causa di forme di orticaria cronica.
- il giallo-tartrazina (E102), colorante che conferisce agli alimenti un piacevole colore giallo limone, presente in diverse bevande, sottaceti, salse confezionate, maionese, minestre in scatola, budini. Può essere causa di orticaria cronica e asma.
- anidride solforosa (E220) che si può trovare in marmellate, succhi di frutta, vini e in macedonie e insalate trattate nei ristoranti con spray per mantenere un aspetto fresco.
- solfiti, metabisolfiti, bisolfiti (E221,E222,E223,E224 ,E225,E226,E227) presenti nei prodotti preconfezionati a scopo conservante e antiossidante, pericolosi soprattutto per le persone asmatiche.
- glutammati (E620,E621,E622,E623) che si trovano soprattutto nei croccantini al formaggio, patatine, ketchup, sughi pronti, riso e pasta liofilizzati, funghi secchi, insaccati, dadi per cucinare. Vengono addizionati molto spesso ai cibi per esaltarne il sapore ma possono anche essere presenti naturalmente in alcuni alimenti. La cucina cinese, ad esempio, utilizza grandi quantità di glutammato e la reazione che può far seguito all’ingestione di cibo contenente glutammato (malessere generale, mal di testa, arrossamento del viso) viene anche detta ”sindrome da ristorante cinese”.
- i nitrati addizionati agli insaccati e alle carni in scatola e la tiramina componente naturale di alcuni cibi come formaggi, cioccolato, banane, possono provocare emicranie anche a distanza di ore.
Fra le varie allergie alimentari non si può tralasciare di menzionare quella alle proteine del latte. L’allergene in questione è rappresentato dalla frazione proteica del latte, in particolare la lattoglobulina. Può comparire durante i primi 3 mesi di vita o più tardivamente fra i 6 e i 18 mesi. In quest’ultimo caso si tratta prevalentemente di una difettosa risposta della mucosa gastrointestinale (enteropatia) alle proteine del latte, in cui non intervengono gli anticorpi.
Ci sono casi di intolleranza sia al latte vaccino che al latte artificiale. Le manifestazioni cliniche sono varie: fra le più frequenti la dermatite atopica, i sintomi respiratori, il vomito persistente, la diarrea, le coliche intestinali.
La soluzione in questi casi può essere trovata spesso grazie alla disponibilità in commercio di tanti latte artificiali ”speciali” come quelli ipoallergenici (contraddistinti in genere dalla sigla HA dove HA sta per hypoallergenic), preparati con proteine già frammentate quindi molto più digeribili e tollerabili, o quelli a base di proteine di soia. In alcuni bambini, tuttavia, queste alternative possono risultare a loro volta scarsamente tollerate.
Un capitolo a parte va dedicato alla celiachia o morbo celiaco, difficilmente classificabile fra le comuni allergie e non intolleranze in quanto coinvolge fortemente il sistema immunitario, senza però chiamare in causa le IgE. In pratica si tratta di un’intolleranza permanente al glutine, proteina presente nei cereali come grano, segale, avena, orzo, farro. Il glutine contenuto nel riso, nel mais, nella fecola di patate o nella tapioca non è pericoloso e pertanto questi alimenti possono essere assunti anche dai pazienti celiaci. Il glutine causa nell’intestino una vera e propria reazione tossica che comporta una profonda alterazione delle pareti intestinali e di conseguenza una compromissione dell’assorbimento del cibo e dello stato nutrizionale del paziente. In questi casi è indispensabile utilizzare alimenti privi di glutine.
Parte 2°
Aggiungo un ultimo articolo, ai precedenti , relativo all’allergia alla mela, così frequente tra gli allergici e prevalentemente tra quelli alle betullacee, per chiarire e completare l’acquisizione della possibile, ahimè frequente cross-reattività tra allergia a pollini e alimenti. A termine riporto uno schema sinottico delle così dette reazioni crociate o cross-reattive, preceduto da una breve introduzione. Ritengo che la fotocopia dell’ultima pagina possa essere veramente utile per la sana dieta degli allergici, specialmente durante il periodo della propria reattività.
http://salute24, il sole24 ore. com di Clara Serretta (04/09/2009)
Intolleranti alla mela?
La buccia della mela potrebbe scatenare pericolose reazioni allergiche. Allergici al polline di betulla? In questo caso, attenti alla polpa dello stesso frutto. Come si spiegano queste curiose reazioni incrociate?
Una risposta arriva dalle proteine responsabili delle allergie. Secondo uno studio condotto tra il 2005 e il 2008 dalla Medical University di Vienna e pubblicato sul Journal of Allergy and Clinical Immunology, la maggior parte degli allergeni contenuti da frutta e verdura appartengono soltanto a 4 delle 10.000 famiglie di proteine individuate e quelli di cibi di derivazione animale a 3. Ecco quindi la ragione per cui chi è intollerante, per esempio, al polline della betulla presumibilmente ha una reazione allergica anche a mele, sedano e susine.
Gli allergeni – In particolare, mela contiene due diverse proteine allergeniche: Mal d 1 nella polpa e Mal d 3 nella buccia. La prima ha una struttura degli aminoacidi molto simile a quella della proteina allergenica del polline della betulla, Bet v 1, la seconda a quella della proteina Pru p 3 della pesca. Inoltre, i legami di Mal d 1 si rompono se il frutto viene riscaldato, mentre quelli di Mal d 3 sono resistenti al calore: chi è allergico alla betulla e alla polpa di mela, quindi, può sempre mangiare il frutto se cucinato e berne il succo se pastorizzato, chi è allergico a pesca e buccia, invece, non può avere alcun contatto.
Una simile reazione incrociata avviene anche tra l`allergia agli acari della polvere e quella ai gamberetti o tra l`intolleranza al polline dell`artemisia – la pianta da cui si estrae l`assenzio – e le carote, il sedano o i semi di girasole.
Le ipotesi – Resta da chiarire il motivo per cui sono i pollini a scatenare la prima reazione allergica rispetto ai cibi: i ricercatori sostengono che questo avviene perché i pollini entrano nell`organismo tramite i polmoni e quindi la catena di amminoacidi dei loro allergeni non viene spezzata dalla digestione e raggiunge integra i vasi sanguigni dove attiva la risposta del sistema immunitario. Una volta però che questo è stato stimolato dal polline, diventa più sensibile e reagisce anche quando una proteina simile entra a contatto con la bocca, come avviene nel caso degli allergeni di frutta e verdura.
REATTIVITA ‘ CROCIATA TRA POLLINI E ALIMENTI VEGETALI
Circa il 25 % dei soggetti affetti da pollinosi presentano manifestazioni cliniche di allergia alimentare a frutta e verdura. Questo problema è più frequente nei pazienti allergici a più tipi di pollini (polisensibilizzati). La pollinosi precede quasi sempre la comparsa dell’allergia alimentare. Il paziente può accusare:
- La sindrome orale allergica: caratterizzata da sintomi orali immediati nei punti di contatto con l’alimento (prurito, bruciore al palato, alla lingua, alle labbra con eventuale gonfiore della mucosa oro-labiale, senso di costrizione al faringe, disturbi della deglutizione).
- Quadri clinici o sintomi extra-orali dopo 15-60 minuti dall’assunzione dell’alimento (sintomi gastrointestinali, orticaria/angioedema, edema laringeo, rinite, asma, congiuntivite , edema palpebrale, deformazione congiuntivale … fino allo shock anafilattico).
Le reazioni crociate sono dovute e causate dalla risposta organica alla presenza di sequenze proteiche analoghe, sia nei vari pollini che nella polpa dei vari frutti e delle verdure.
In generale la risposta immunitaria viene scatenata dall’interazione allergene- IgE specifiche, che si trovano normalmente legate a recettori di membrana delle cellule immunocompetenti, quali basofili, mast-cellule ed eosinofili.
Il contatto tra i recettori cellulari sopramenzionati e le proteine vegetali, contenute nei frutti e verdure, chimicamente molto simili all’allergene dei pollini, scatena una reazione allergica, a cui segue la liberazione dei mediatori infiammatori, tra cui capeggia l’istamina, responsabile di vari quadri clinici. La reazione allergica, quindi la liberazione d’istamina, dipende dalla quantità di cibo reattivo introdotto ed è particolarmente spiccata nel periodo della pollinosi.
Pollini con allergeni in comune (cross-reattivi) con gli alimenti
- Betulla, cipressi, ontano, nocciolo, carpini: mela, pera, pesca, albicocca, prugna, ciliegia, nocciola, noce, mandorla, nespola, arachide, lampone, fragola, kiwi, sedano, finocchio, carota, prezzemolo.
- Graminacee: frumento, mais, orzo, avena, riso, segale, melone, anguria, pomodoro, arachide, pesca, ciliegia, albicocca, prugna, mandorla, kiwi, agrumi, bietola.
- Composite – Artemisia, Ambrosia: lattuga, cicoria, tarassaco, camomilla, olio di girasole, margarina, banana, castagna, sedano, finocchio, carota, prezzemolo, pepe verde, sedano, lattuga, miele, miele.
- Parietaria: basilico, ortica, melone, ciliegia, more di gelso, pisello, patata, fagiolo, pistacchio, kiwi.
- BETULLACEE ET ALII: Mela, carota, sedano, finocchio, pera, banana, nespola, pesca, ciliegia, albicocca, prugna, prezzemolo, nocciola, noce, arachide, mandorla, kiwi, lampone, fragola, pepe verde.
- COMPOSITE – ASSENZIO e AMBROSIA: Cicoria, tarassaco, camomilla, banana, anguria, castagne, arachide, noce, nocciola, pistacchio, sedano, prezzemolo, carota, finocchio, olio di girasole, margarine, dragoncello, lattuga, zucca, mela, melone, miele di girasole, miele di tarassaco.
- PARIERARIA: Pisello, arachide, soia, fagiolo, gelso, pistacchio, melone, kiwi, patata, basilico, ortica, ciliegia, basilico.
- GRAMINACEE: Sedano, orzo, avena, kiwi, mais, anguria, pesca, prugna, agrumi, riso, segale, frumento, pomodoro, melone, albicocca, ciliegia, mandorla, arachidi, bietole.
Autore: Dott.ssa Cinzia Baldo – Dietista – ICP P.O. Buzzi Milan
http://www.educazione nutrizionale granapadano.it
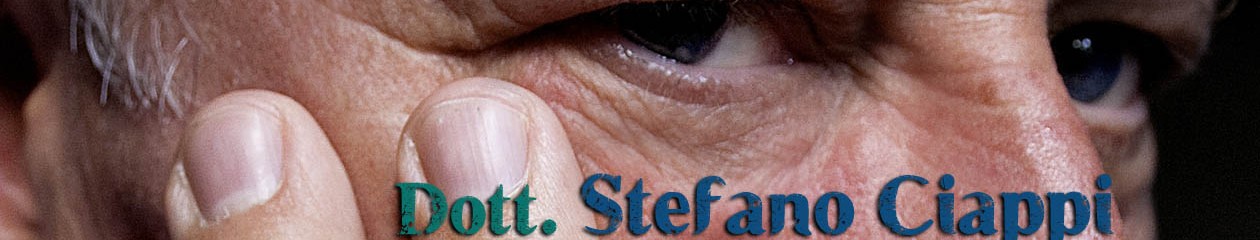
Mio figlio di 15 mesi e’ allergico ai fiori Dell ulivo
Viviamo in campagna e questo non ci aiuta affatto
Gli di infiammano le congiuntive con occhi rossi e prurito
Alla palpebre.
Aiuto
buon giorno sono allergica al cipresso.
quali alimenti devo evitare?
solo nel periodo della fioritura?
grazie
L’allergia alla proteina contenuta nei pollini del cipresso si ritrova in molti altri frutti e verdure.
Ne risulta una complessa cross-reattività che trova nel sito.
Cordialmente
Stefano Ciappi
Il R. omeopatico più noto a tal proposito è Euphrasia.
Mi perdoni il ritardo ma mi era sfuggita questa sua richiesta.
Stefano Ciappi
chiedevo un rimedio omeopatico per affrontare un allergia svilupata alle pinate a fioritura precoce tipo:nocciolo,cipresso e allegia al tiglio
presento sternuti frequenti,secrezione acquosa dal naso e lieve fastidio agli occhi
Gent. ma Sabina,
da quanto mi scrive partirei con Nux Vomica, 9CH,Cemon, assumendone 4-5 granuli sublinguali più volte al dì ed in funzione dei sintomi.
Mi faccia sapere.
Cordialmente
Stefano Ciappi
Potrebbero esser vere entrambe le ipotesi, ovvero che il vaccino non è stato del tutto capace di debellare la sua reattività specifica e che nel momento topico le Ige si sono mosse reattivamente.
Non mi ha parlato di sintomatologia soggettiva.
Se è stato meglio ha fatto comunque una soppressione clinica
Cordialmente
Stefano Ciappi
buona sera sono celiaca e sono allergica alla soia,mais,frutta,verdura!mangio solo farina di riso cosa posso fare?mi consigliate un esame molecolare?
Salve dottore
Io sono allergico al cipresso dell arizona…prendo 5 granuli al giorno di “pollensi” ( medicinale omeopatico)… È corretto? Oppure ho bisogno di altri medicinali omeopatici??
Grazie
Il prodotto che usa è un isoterapico e non propriamente un rimedio omeopatico, ovvero sta cercando
di curare l suoi sintomi allergici spontanei con un prodotto diluito e dinamizzato prodotto a partire da un
insieme di pollini vari.
In altre parole usa il principio dell’identità e non della similitudine che prevede di usare un rimedio x, la
patogenesi sperimentale (prufung) del quale ha prodotto nei proving sintomi identici ai suoi.
Le consiglio di rivolgersi ad un omeopata unicista.
Cordialmente
S.C
Molte sono le piante, ortaggi e frutti da evitare per non incorrere nelle reazioni crociate.
Cerchi le voci per tutelarsi.
saluti
S.C
Buongiorno, io sono allergica alla thuja. Quindi,congiuntivite,lacrimazione,naso che cola,prurito alla gola labbra e condotto uditivo, sinusite. Il mio medico mi ha prescritto pafinur. Il fastidio è cessato ma mi si è riacutizzata la sinusite. Che antistaminico dovrei assumere? Oppure, esiste una cura omeopatica? Grazie.
A mio avviso dovrebbe rivolgersi ad un omeopata della sua città accertandosi che sia
un unicista e non un complessista o omotossicologo.
Luffa op. potrebbe essere un valido suggerimento, non conoscendola, da trincea.
se è freddolosa spesso silicea è utile, eventualmente rafforzata dall’uso di
Silicium organicun 5 senza conservanti, commercializzato dalla ditta Freeland.
Saluti
S.C
Salve io sono ciliaca , e allergica a gramminaccee , Lavoro in una negozio di un panificio, Che rieschi sono ??
Purtroppo molti.
Il glutine si forma con l’impastatura delle farine.
Deve evitare di mangiare cibi al glutine come tutti ed evitare il contatto
con il pane.
Cordialmente
s.C
Grazie
Saluti
Dicono che le intolleranze aumentano le allergie.Mia figlia è allergica la bet-v 1 , al pomodoro e al cipresso:Ora intollerante anche al grano,al lievito e al latte.Siamo disperati perché ha problemi gastrointestinali importanti che stanno sottovalutando dandole continuamente omeprazolo riopangel e levopraid, ma continua a star male. I cali di pressione cominciano a divntare frequenti(min.39-max 69>) e tachicardia:Nessuno prende seriamente in considerazione il caso.Mia filglia ha 19 anni.Grazie
Dicono che le intolleranze aumentano le allergie.Mia figlia(19 anni) è allergica al bet-v 1,al pomodoro e al cipresso.Ora intollerante al grano,lieviti e latte.Siamo disperati perchèha problemi gastrointestinali importanti che stanno sottovalutando dandole continuamente omeprazolo,levopraid e riopangel,nonostande continui a star male:I cali di pressione stanno diventando piu’ frequenti (min.39-mx69) .Nessuno prende seriamente in considerazione il caso.Grazie
Le intolleranze non sono allergia ma “parenti stretti” .
Se crede possiamo vederci in uno dei miei Studi, altrimenti non ho
modo di esserle di aiuto.
Cordialmente
S.C
Buongiorno
Io sono allergica a vari pollini i peggiori graminacee e Olivo.
Mi chiedevo…al di là della allergie crociate alimentari che già conosco purtroppo…mi chiedevo se assumere per via orale delle capsule di fibre che contengono estratto secco liofilizzato di foglia di Olea Europea possa essere controproducente. Potrebbe innescare qualche meccanismo allergico?
grazie
ilaria
La reazione allergica avviene tra le proteine specifiche dei vari pollini od allergeni (uova, latte-latticini)
e l’organismo, in maniera selettiva.
Essere allergici ai cipressi o all’olivo (pollini) non vuol dire essere allergici a ogni parte della pianta.
Saluti
S:C
buon giorno, è consigliabile fare i vaccini contro l’ambrosia? sono allergica agli acari ambrosia nichel e cobalto.. mi hanno consigliato almeno quello all ambrosia così da limitare un pò i danni.
salve. o allergia da graminacee e olivo, voglio sapere se posso usa vaccine per tutte due nello steso tempo , e in qualle periodo li devo cominciare?grazie
Gli Omeopati non usano vaccini specifici.
Il principio della similitudine è diverso dall’uso dell’identico.
I vari prodotti antivirali basati sulla diluizione e dinamizzazione di ceppi
batterici e virali non è omeopatia ma Isoterapia.
Spero di esser stato chiaro
Cordialmente
S.C
Gli Omeopati non apprezzano i vaccini, specialmente quelli agli allergeni inalanti.
La cura omeopatica si basa sui sintomi soggettivi e reattivi individuali.
Per una desensibilizzazione generica ed ampia le consiglio la Micoterapia con
MICO REI della ditta Freeland, assumendone 2 cps al di, lontano dai pasti e con
acqua-limone o pompelmo.
Quale “antistaminico” naturale e curativo, le consiglio TERPENAL plus della ditta
Pharma extracta, assumendone 1-2 al d’ a stomaco vuoto.
Cordialmente
S.C
Buongiorno Dottore, volevo chiederle ho 49 ann e dal 20 13 ho scoperto di essere allergico alle urticacee( mediante test allergici con aghetti). Sintomatologia principale: prurito d lacrimazione occhi, occlusione naso con forte prurito e secrezione abbondante muco, forte prurito (come ortaria tessuti molli) cavo orale principalmente al palato . Cosa posso fare? Esistono cure adatte. Magari con prodotti meno dannosi per l’organismo (es. reni) di cui soffro da tempo? Non saprei a chi rivolgermi abito in provincia di Torino. Ringraziandola anticipatamente Le porgo Cordiali saluti.
Gent.mo Gianni,
si procuri Sabadilla 5 oppure 9CH, della ditta Cemon-Unda, in granuli i gocce,
comunque quello che trova prima disponibile.
Assuma comunque 4gr. ogni 6-12 ore per via sublinguale, lontano dai pasti, bibite,ecc.
Mi faccia sapere come sta tra 3 settimane circa.
Saluti
S.C
Buonasera Dottore,
mio figlio di 15 anni è allergico alla parietaria, all’ulivo e all’acaro (prick test). Ho seguito, su indicazione del medico (omeopata unicista), il seguente protocollo:
il 1 febbraio Sulfur 200ch (unda) tubo dose
+ Oligosol Manganese Labcatal
Dal 1 marzo e per tutto il periodo della pollinazione: Engystol > 1 compr. x 2 volte al dì + Allergy plex 29 > 20 gocce x 2 volte al giorno
Vorrei un suo cortese parere in merito
Grazie e cordiali saluti
L’unica cosa che posso dire è che non mi pare la scelta terapeutica di un Unicista
perchè usa composti graditi dalla tecnica omotossicologica ma non dagli omeopati
Hahnemanniani.
S.C
Buongiorno Dott.re,
Mia figlia di 16 anni e’ allergica alla parietaria e agli acari; mentre io sono allergica all’ulivo, graminacee e cipresso, ci consiglia una cura omeopatica adeguata per ciascuna allergia.
La ringrazio
Roberta
Fate un salto a Firenze e ne parliamo.
le cure vanno personalizzate.
S.C
Salve, ho fatto prove cutanee diagnostiche per le malattie allergologiche nel 2004 e nel 2011, con risultati diversi .. nelle ultime,comunque,son risultato essere allergico a cipresso,graminacee e debolm positivo alle paretarie.. i miei problemi di muco eccessivo, raffreddori vari ,tosse son tutto l’anno . Secondo i medici dovrei prendere sempre antistaminici e spray nasali. Mi pare eccessivo ,tutto l’anno no?
Gent.mo Marko Russo,
è molto difficile dare una risposta certa.
Se i sintomi lo riguardano sempre sembrerebbe logico doverli sopprimere sempre.
Le consiglierei di rivolgersi ad un Omeopata per farsi curare e non sopprimere i sintomi.
Cordialmente
S.C
Per quanto riguarda le reazioni “cross crociati” per la mela e la pera che appartengono alla famiglia delle rosacee e sono menzionate tra gli alimenti che provocano reazioni, per quanto riguarda la “rosa canina” presa sotto forma di infuso e facente parte della famiglia delle rosacee, potrebbe ugualmente dare problemi?
Grazie
Potenzialmente si ma la reattività delle mele è particolarmente
spiccata nella buccia, ovvero lo scudo protettore dei vari frutti.
saluti
S.C
Buona sera dottore,
chiedo aiuto perché sono allergica al cipresso,olivo,betulla,graminacee,ambrosia.
esiste un atistaminico naturale ? perché essendo allergica anche al mais molti farmaci non posso usarli….
Un buon prodotto per l’allergia, ovvero per modulare la risposta allergica,
è HomeoPharm TH2 della Ditta Cemon.
Ne assuma 2 misurini al dì
Gli antistaminici “naturali” sono tanti e da scegliere sui sintomi individuali
caratteristici.
Saluti
S.c
Mamma di ragazzino quindicenne che da tre anni si rapporta con allergia al cipresso e debole all’acaro della polvere, ho trovato molto chiaro l’articolo ed illuminante rispetto al problema di mio figlio. Grazie molte!!!
mamma di un ragazzino quindicenne che da tre anni si rapporta con una pesante reazione allergica tra febbraio e marzo al cipresso ed una leggera allergia all’acaro della polvere. L’articolo chiaro ed illuminante , tante grazie!!
Un nuovo aiuto per modulare la risposta allergica è un prodotto, ahimè composto, della Cemon,
TH2 modulatorio.
Non ho comunque dati sufficienti per suggerirle nessuna terapia specifica.
Cordialmente
S.C
Buongiorno, ho scoperto di essere severamente allergica alla lanciuola. Purtroppo trovo davvero poche informazioni al riguardo, e sono curiosa di sapere se croci con qualche altra erba o alimento. Grazie mille, chiara
Sono i sintomi reattivi che fanno scegliere il Rimedio, non necessariamente la
eziologia.
Saluti
S.C
Buongiorno Dottore,
mia figlia ha 22 anni, è allergica alle Graminacee: Erba canina con valore nel sangue di 12,50 e Loglierella di 32,00, più allergia acari della polvere con valore 2,50 nel sangue. I suoi sintomi sono tutti dermatologici : cheilite sulle labbra (edema con vescicole disquamanti) chiazze sul collo con prurito e gonfiore occhi. Ha provato con antistaminici e crema al cortisone o antibiotica con poco risultato. Mi potrebbe indicare un prodotto omeopatico o crema? E’ utile anche limitare gli alimenti ? grazie mille
Gent.ma Silvia,
aspettando di vedervi in Studio per una terapia mirata, Le consiglio
Rhus Tox, 30 Ch, 4 granuli la sera.
Saluti
Buonasera, è possibile che un soggetto allergico al cipresso abbia una reazione a una crema contenente estratto di foglia e stelo di cipresso? La ringrazio
Certamente.
Esiste inoltre la possibilità di avere una reazione crociata ad esempio al sedano e d altro.
Saluti
Stefano Ciappi
Si. Si documenti sull’argomento reazioni allergiche crociate.
Stefano Ciappi